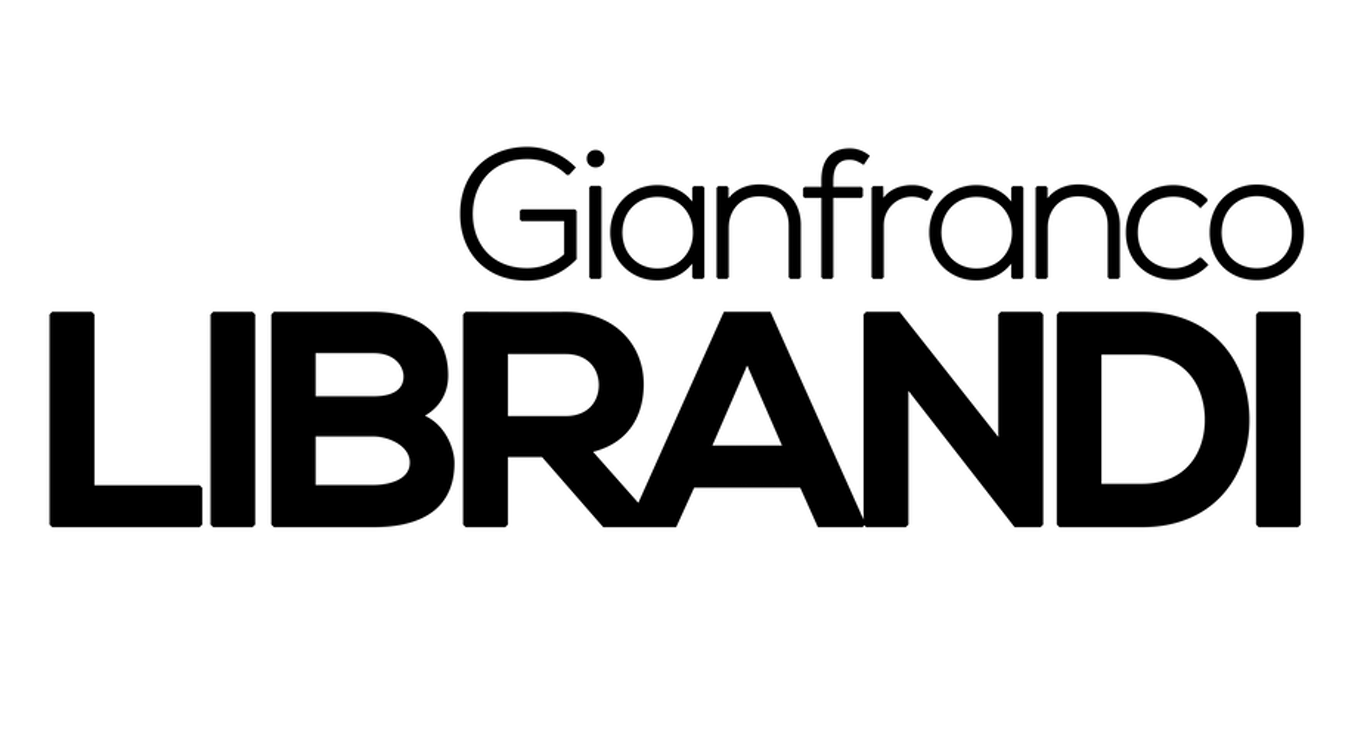Articolo di Gianfranco Librandi pubblicato il 5 maggio 2015 sul sito di informazione Stradeonline.it
Articolo di Gianfranco Librandi pubblicato il 5 maggio 2015 sul sito di informazione Stradeonline.it
Il blocco della rivalutazione degli assegni previdenziali sopra tre volte il minimo per gli anni 2012 e il 2013 – decisione assunta nel 2011 dal governo Monti con il voto favorevole di centrodestra e centrosinistra – fu dettato da una profonda necessità del Paese: mettere in salvo i conti dello Stato, assicurare il pagamento di tutte le pensioni (soprattutto di quelle dei meno abbienti) e restituire un futuro ai giovani italiani.

Chissà se la Corte Costituzionale, nell’eccepire un difetto di motivazione per quella scelta, ha riflettuto sul fatto che quel decreto-legge è passato alla storia con il nome di “Salva Italia”. O se ha analizzato la curva degli spread. Ma tant’è.
Quella necessità di equità tra le generazioni è ancora profondamente attuale e nessuno – a mio parere – può sostenere che non si tratti di un principio fondante della costituzione formale e sostanziale del Paese. Per questo, sono certo che molti cittadini aventi diritto a quel rimborso pensano che sia sbagliato, soprattutto in questa fase storica, scaricare un costo ulteriore sul futuro e su chi lo vivrà. Anche perché, detto con franchezza, quei rimborsi finiranno per aumentare ancora di più la differenza tra i contributi effettivamente versati e gli assegni goduti.
Quel rimborso è un diritto, ma non un obbligo. Lancio una proposta: costituiamo un comitato “Non vogliamo il rimborso”, cui possano iscriversi e partecipare quanti credono che un’Italia migliore si costruisce anche a partire dalla rinuncia di questi “diritti acquisiti”. Il comitato sarebbe la testimonianza più esplicita che c’è un’Italia che ha ormai cambiato profondamente mentalità, scegliendo le leve della responsabilità e dell’equità.